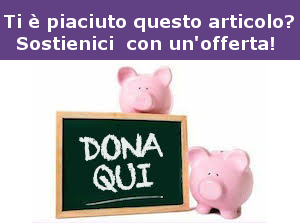Il buco film di Michelangelo Frammartino in Concorso a Venezia78 ci riporta all’esplorazione dell’Abisso del Bifurto nel 1961.
Si spengono le luci in sala. È buio e rimane così per lunghi istanti. Man mano si iniziano a sentire le gocce che battono su delle rocce che non vediamo. Gradualmente, una lunga dissolvenza apre sull’ingresso di una grotta come se fosse notte. Una notte che lentamente dà spazio al giorno e al sole. La sala si apre sull’ingresso di una grotta che incornicia degli alberi. Il cielo intravisto diventa sempre più terso man mano che passano gli istanti. La Natura si risveglia, fuori campo. Ma noi la sentiamo. Poi iniziano a sentirsi uno scampanellio, dei muggiti e delle voci lontane. All’imbocco della grotta vediamo palesarsi un paio di corna e poi un altro. Due mucche fanno capolino sull’abisso e guardano gli spettatori in sala. Sentiamo i richiami del pastore, e ancora qualche lieve scampanellio. Poi stacco, di nuovo buio.
Lo spettatore non uscirà più da questo buco. Questa è la prima immagine de Il buco il film di Michelangelo Frammartino presentato in Concorso alla 78^ Mostra di Arte Cinematografica di Venezia. Un lavoro che il direttore Alberto Barbera ha scelto dopo esserne rimasto folgorato in quanto. «È un film che ha la bellezza assoluta del diamante puro» – queste le sue parole. Un film nato da una sensazione. La sensazione di profondità che dà un sasso gettato e che non senti cadere se non dopo lungo tempo. Un sasso buttato da un sindaco che accompagnò Frammartino nel Parco del Pollino, in Calabria, mentre lavorava a Le quattro volte. Era il gennaio del 2007 e il sasso cadde in un taglio del terreno nei pressi di una dolina. E da lì non se ne è più andato.

Quel taglio nel terreno era l’imboccatura dell’Abisso del Bifurto (conosciuto anche come “Fossa del lupo”) una delle grotte più profonde al mondo. Venne esplorata la prima volta da un gruppo di speleologi piemontesi nel 1961. Era il boom economico ed era stato da poco inaugurato il grattacielo Pirelli a Milano. Allora era l’edificio più alto d’Europa con i suoi 127 metri. Una altezza che era stata portata a casa degli italiani tramite le riprese televisive. Esse salgono gradualmente fino a mostrare, tramite un tilt up (panoramica verticale verso l’alto), il paesaggio urbano dalla cima. Di contro, nel cuore della Calabria un pastore scopre una grotta e dei membri del Gruppo Speleologico Piemontese decidono di intraprendere un viaggio. Da nord verso sud per scendere poi ancora più in basso.
Le quattro volte: una ritualità a rischio estinzione
Quello che scoprono è un autentico Abisso (nome più che mai adatto) nel quale si perdono i suoni e la luce. Man mano che vengono gettati fogli di giornale infiammati in avanscoperta, le pareti si tingono di arancione per pochi istanti. Un bagliore di luce per poi ritornare nelle tenebre. Sono montate scalette, corde, tiranti, si passa in cunicoli via via più stretti. Gli speleologi uno dopo l’altro vengono ingoiati dalle tenebre. Sono gli intrusi in un mondo sconosciuto e potenzialmente ostile.
La storia de Il buco è la storia di questa scoperta. Si tratta del primo film puramente di finzione di Frammartino. Ma una finzione che rinuncia deliberatamente alla drammatizzazione. Una finzione che ha l’oggettività del documentario. Quando non siamo immersi nelle profondità rocciose, noi vediamo i preparativi dell’esplorazione, l’arrivo in una stazione lungo la costa al tramonto. Con, sullo sfondo, un faro che proietta la luce a lunga distanza. Un bagliore che il pastore, dall’entroterra vede, accompagnato dal suo fedele mulo.

Solo a lui Frammartino riserva dei primi piani. La pelle incanalata dalle rughe, mentre richiama costantemente le sue bestie. Lui rappresenta il cuore di quell’altopiano dove è situato l’abisso. Dall’alto della sua casa fatta di legno di recupero o accanto al suo fedele albero, dal quale vede, da lontano, avvicinarsi il camion con la comitiva di nuovi arrivati. A lui viene affidata la parte maggiormente empatica del film e sul quale ci concentriamo. Lui ci ricorda, come il pastore di pecore de Le quattro volte della transitorietà dell’elemento umano in paesaggi come questi e non solo. Lui è lo spirito silente di queste Terre. La metafora di un mondo arcaico e ancora del tutto sconosciuto da esplorare. Per ricordarci cosa conta davvero.
The Power of the Dog – L’Uomo Naturale nel West a Venezia 78
Un’altra scena è extradiegetica. Il regista e la troupe si sono presentati sul red carpet e in sala con la tuta da utilizzata all’epoca. I protagonisti sono interpretati da veri giovani speleologi. Ma erano presenti in sala anche alcuni dei reali autori dell’esplorazione. Essi erano commossi perché, dopo aver percorso l’oscurità per tutta la vita, hanno avuto il loro momento di luce. Una luce bianca che occupa tutto lo schermo del cinema prima che torni di nuovo il nero, e che si riaccendano le luci in sala.