La Laguna di Venezia è un luogo di percorsi che si incrociano. Quasi un labirinto modellato dall’azione della natura ma anche un luogo corretto dall’opera umana che nei secoli ha consolidato, scavato, bonificato. Per questo Venezia è stata più volte equiparata a una officina dinamica e operosa: diverse le sue attività di costruzione ma anche quelle per l’approvvigionamento, la manutenzione, il trasporto, la conservazione. Un incessante laboratorio di sperimentazioni tecnologiche originali ma ugualmente efficaci che risultano essere una concreta e tangibile risposta alle problematiche di un ambiente singolare ma anche ostile.
La città si raccoglie e si proietta sulla sua laguna, sui lidi e oltre: lungo i canali e i “ghebi”, le valli, le velme, le barene e le paludi con un un incessante moto che è quello delle maree. Venezia che attraversa l’acqua, è un luogo urbano dalla doppia viabilità: terrestre e acquea. Sì perché qui il territorio è l’acqua e se si vuole cogliere il vero senso di questa città straordinaria, è necessario ripercorrerne brevemente il percorso della sua formazione, del suo insediarsi sull’acqua. Qui non ci sono, come da altre parti, solidi terreni sui quali sia possibile tracciare in modo abbastanza chiaro la storia della sua conformazione ma ci si deve affidare alle fonti archivistiche e ai ritrovamenti archeologici.

Generalmente le città nascono e si sviluppano attorno a un nucleo centrale che spesso è una chiesa oppure un incrocio di strade, un porto o un castello. Venezia invece si configura come un conglomerato casuale ma armonioso, un insieme di terre emerse e di piccole isole molto meno estese, nel loro insieme, rispetto agli spazi acquei che le separano. Ma si potrebbe anche dire che Venezia sorge su una vera a propria foresta di alberi. Boschi interi sono stati utilizzati per edificare la città che, poggiandosi su terreni paludosi e spesso artificiali, impiegava metodi e tecnologie che fin dalle origini erano molto onerose e non solo economicamente. Ecco perché queste soluzioni ebbero una grande ripercussione nel configurare il vero volto della città e la sua forma. Ogni volta che si metteva mano a un edificio, si riutilizzavano materiali lasciando le fondazioni dove erano state costruite: la logica è attualissima ed è quella del risparmio, riciclo e riutilizzo. E a Venezia anche certi rifiuti venivano riutilizzati con soluzioni creative per non dire geniali!
Venezia quindi è “appoggiata” sopra una specie di grande bosco rovesciato. Pochi infatti si rendono conto, gironzolando fra calli e campielli, che tutto si poggia su enormi quantità di pali di legno, milioni e milioni, che venivano trasportati, anzi fluitati, dagli zattieri dai boschi delle montagne lungo i fiumi fino ad arrivare in città. E questo era l’unico modo per costruire edifici sulla sabbia. Sotto la Basilica della Salute gli archeologi ne hanno rinvenuti circa centomila e a anche ai piedi del ponte di Rialto, per contenere la spinta dell’arco di pietra ce ne sono in un numero davvero ingente.

La Basilica di San Marco poggia su zatteroni di legno eseguiti con tavelle incrociate fra loro che, adagiandosi sugli strati più sabbiosi, consentivano l’appoggio di blocchi di pietra di rovere sostenuti da una palafitta di olmi.
Da questi primitivi interventi si mise a punto una soluzione complessa che, dopo le prime applicazioni, assunse la configurazione di un sistema a strati dove il più basso, che era immerso, era costituito da pali in legno di ontano, olmo e larice, con una disposizione che campiva l’intera superficie (della a platea) oppure lungo i muri lunghi da due a tre metri appuntiti e conficcati fino allo strato di caranto. Questi pali, che avevano le teste segate, potevano sostenere un tavolato di legno e poi un basamento di pietra, un altro strato di pietra d’Istria sul quale poggiavano le mura delle case. I pali in acqua subiscono un processo che li indurisce. Questa è una delle soluzioni tecnologiche che ebbero una grande ripercussione!
Il rapporto con l’ambiente circostante per quanto riguarda l’approvvigionamento continuo della materia prima per il nuovo impianto e per la continua sostituzione dei manufatti, è evidente. Un palo infisso in laguna dura in media dieci anni dopo di che deve essere sostituito perché si corrode nella tratto che corrisponde all’escursione di marea che diventa habitat naturale di organismi deleteri per la sua conservazione.
La Repubblica di Venezia è da sempre stata accusata di aver depauperato per suo uso il patrimonio boschivo delle Alpi venete e probabilmente non avrebbe potuto sopravvivere se all’origine non avesse avuto intorno boschi a cui attingere fino al suo esaurimento il proprio fabbisogno energetico e di materiali per le case, per il consolidamento del suolo e per le navi. Da una parte c’era la necessità di avere legname sempre a disposizione che portava al taglio del bosco, dall’altra quella di conservare il bosco per contenere le acque a monte evitando piene e inondazioni a valle e impedendo contemporaneamente l’interramento della laguna. Rimboschimento e diversione dei fiumi ai margini della laguna furono operazioni strettamente correlate per la salvaguardia della laguna della città e di tutto il suo ambiente.
Allora la prossima volta che andate a Venezia siate osservatori più attenti e cercate di percepire la foresta invisibile. Le foreste di alberi sono talmente presenti e radicate nel paesaggio veneziano che a volte passano inosservate.
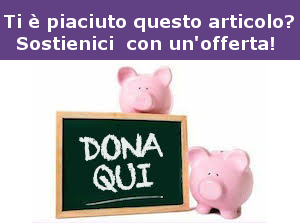










Mi è piaciuto molto l’articolo. Ci sono musei a Venezia che testimoniano la storia delle fondamenta boschive della città?
Caro Massimo, ci sono parecchie pubblicazioni in merito e ti posso segnalare che a suo tempo il prof Ennio Concina se ne era occupato nei suoi saggi dedicati all’Arsenale di Venezia. In rete puoi trovare anche un articolo di un mio omonimo http://www.academia.edu/8707817/_Boschi_legnami_costruzioni_navali._L_Arsenale_di_Venezia_fra_XVI_e_XVIII_secolo_Archivio_veneto_CXLV_2014_s._VI_n._7_pp._111-175
Quanto ai musei, ti consiglio un giro al Museo di Storia Naturale di Venezia ma anche una visita all’Arsenale. Continua a seguirci