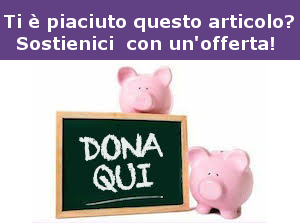La valanga sull’Everest del 18 aprile ha causato 15 morti e molti dispersi. Le vittime preparavano corde ed equipaggiamenti per i turisti in vista dell’alta stagione.
Venerdì 18 aprile 2014, ore 06.45. Dal versante orientale del monte Everest, esattamente a 5800 m di quota, si stacca una valanga che arriva fino a Popocorn Field, la serie di crepacci da superare per giungere al campo 1.
I dati parlano di almeno 15 morti, trasformando questo evento nella tragedia più grave nella storia di questa vetta del mondo, e si cercano ancora molti dispersi.
Oltre alla valanga sull’Everest, sempre il 18 aprile, nella stessa zona, uno sherpa ha perso la vita a causa dell’instabilità del ghiaccio dovuta alle temperature più miti.
Questa è la stagione più adatta alla scalata: il clima invernale ne rende impossibile l’accesso nei restanti periodi dell’anno, e, perciò centinaia di persone affollano il campo base, divenuto una specie di villaggio popolato da sherpa e stranieri in cerca dell’impresa.
Nessuno di loro, ieri mattina, si aspettava un evento simile: in tanti anni in cui questa cima ha costituito il sogno di numerosi scalatori, molto più rispetto agli altri tredici ottomila, si sono verificati molti incidenti, ma finora non di questa portata.
Errori umani? Destino?
Certamente è più facile liquidare la questione come una fatalità, una tragedia e un rischio da calcolare quando si affrontano certe avventure.
Premesso che in montagna si deve essere consapevoli di quello che si sta facendo, prendendo le precauzioni adatte ed affrontando l’ambiente con il dovuto rispetto e preparazione, specie per non mettere in pericolo se stessi e gli altri (anche i soccorritori), è molto importante per tutto il nostro sistema climatico non chiudere gli occhi di fronte alle tragedie annunciate.
Prima di tutto, è nei ghiacciai che noi vediamo quanto il nostro clima si sta surriscaldando. Oltre all’instabilità dei crepacci del monte Everest, possiamo verificarlo anche lungo il sistema alpino: infatti, in 50 anni, dalle Alpi Giulie sono scomparsi due dei sette ghiacciai censiti nel 1962, e in tutto l’arco alpino possiamo verificare il loro ritiro con percentuali che si aggirano intorno al 50%.
Dal 2011 al 2013 il ghiaccio perenne sul Tetto Del Mondo è diminuito di quasi 50 metri, il doppio della sua media annuale, causando danni e mettendo a rischio la riserva d’acqua dolce cruciale per il sistema economico e ambientale dell’intera Asia.
Inoltre, i 1600 laghi glaciali del monte stanno raggiungendo velocemente il limite di capacità – vi ricordate cosa successe al suo superamento al lago artificiale sulla diga del Vajont?
La causa di questo fenomeno è il global warming.
I Governi europei continuano a non prendere una posizione rispetto a questo tema, cincischiando tra dichiarazioni d’intenti e obiettivi sempre più lontani rispetto al termine che ci si era prefissati in accordi precedenti.
Accanto a questo, lo spopolamento montano è favorito da politiche totalmente rivolte alla città industrializzata ed inquinata, che si dimentica delle sue valli e montagne (a parte quando deve bucarle per ricevere finanziamenti europei o spianarle per costruire gli Snowpark).
Questo aggrava la crisi che sta attraversando l’intero ecosistema, in cui anche l’impegno dei singoli è inondato dal mare della burocrazia e degli interessi della città.
Senza conoscenza del territorio e attenzione verso il clima, le tragedie diventano la regola e la conseguenza annunciata del nostro disinteresse.
La guida indispensabile al cambiamento climatico: un libro racconta cosa sta succedendo alla Terra
La valanga sull’Everest non può lasciarci indifferenti. Quando non ci saranno più ghiacciai, e la montagna sarà totalmente abbandonata e rovinata dal riscaldamento climatico, come freneremo il dissesto idrogeologico? Come alimenteremo i fiumi? Quale acqua berremo?